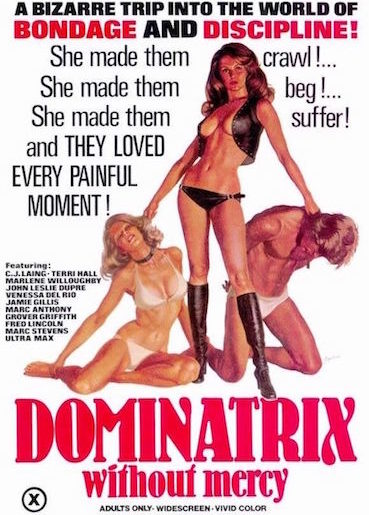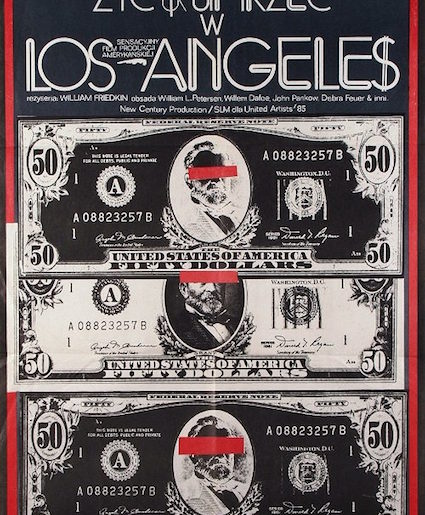L’erotico-esotico più anomalo e sorprendente. Un film destinato a perdersi nelle onde di quello stesso oceano ripreso in modo mai così minaccioso e pericoloso
Film che chiude la trilogia con Zeudi Araya, ma anche film profondamente sentito, frutto di un’elaborazione molto personale all’interno di una dimensione onirica e di desiderio. Luigi Scattini chiude il cerchio e confeziona un’opera non convenzionale (per il genere), profondamente irrisolta e proprio per questo ancor più affascinante. Un film d’atmosfera mortifera in cui non c’è spazio né per il sole né per l’amore. Un film destinato (inevitabilmente – dati i presupposti) a perdersi nelle onde di quello stesso oceano ripreso in modo mai così minaccioso e pericoloso. Ne Il corpo, la storia raccontata è secondaria – e a poco o nulla serve ricondurla all’opera di James Cain “Il postino suona sempre due volte”, perché in questo caso si tratta di un puro e semplice pretesto necessario ad imbastire il film e a tenerlo assieme alla bene e meglio per evitare che sfugga dalle mani. Il corpo è un film che doveva essere altro ma che, incredibilmente delle intenzioni iniziali – disattese e mai portate a compimento – conserva, sotto traccia, tutta la forza dirompente della tragedia esistenziale anche se virata sulle corde del fumetto erotico.
 La sceneggiatura definisce il personaggio di Antoine con tratti hemingwayani e distilla nei dialoghi citazioni – più o meno occulte – di Conrad, dello stesso Hemingway e James Cain. Dell’idea iniziale rimangono l’isolotto di fronte a Trinidad (“luogo ideale e irreale”) e tre personaggi che altro non sono che tre corpi alla deriva aggrappati con le unghie e con i denti, a quel che rimane del sogno caraibico. Personaggi monocordi le cui psicologie sono appena abbozzate così come lo sono le loro origini, nonché gli oscuri motivi che li hanno spinti a ritrovarsi su quei pochi metri di terra, roccia e mangrovie in mezzo all’oceano. Due uomini (Antoine e Alain) e una donna (Princess), più un’altra, Madeleine – moglie di Antoine – che vive sulla terra ferma (a Port-of-Spain) rabbiosi e imbelli, stretti nella morsa del loro egoismo, della loro solitudine e di un caldo soffocante che fa sudare i corpi e annebbia la mente. Giornate trascorse in attesa del nulla, in un inverno caraibico che schiaccia come una cappa opprimente e che toglie il respiro sotto un cielo plumbeo mai così basso e caliginoso. Nessun personaggio positivo, nessuno slancio di generosità, nessuna vocazione alla solidarietà e all’altruismo, nessun contatto né amicale né amoroso – bensì solo sesso fintamente esotico e sodomitico, litri di rhum gelato da ingollare a perdifiato e relazioni oscene perché prive di qualsivoglia afflato gioioso e spontaneo.
La sceneggiatura definisce il personaggio di Antoine con tratti hemingwayani e distilla nei dialoghi citazioni – più o meno occulte – di Conrad, dello stesso Hemingway e James Cain. Dell’idea iniziale rimangono l’isolotto di fronte a Trinidad (“luogo ideale e irreale”) e tre personaggi che altro non sono che tre corpi alla deriva aggrappati con le unghie e con i denti, a quel che rimane del sogno caraibico. Personaggi monocordi le cui psicologie sono appena abbozzate così come lo sono le loro origini, nonché gli oscuri motivi che li hanno spinti a ritrovarsi su quei pochi metri di terra, roccia e mangrovie in mezzo all’oceano. Due uomini (Antoine e Alain) e una donna (Princess), più un’altra, Madeleine – moglie di Antoine – che vive sulla terra ferma (a Port-of-Spain) rabbiosi e imbelli, stretti nella morsa del loro egoismo, della loro solitudine e di un caldo soffocante che fa sudare i corpi e annebbia la mente. Giornate trascorse in attesa del nulla, in un inverno caraibico che schiaccia come una cappa opprimente e che toglie il respiro sotto un cielo plumbeo mai così basso e caliginoso. Nessun personaggio positivo, nessuno slancio di generosità, nessuna vocazione alla solidarietà e all’altruismo, nessun contatto né amicale né amoroso – bensì solo sesso fintamente esotico e sodomitico, litri di rhum gelato da ingollare a perdifiato e relazioni oscene perché prive di qualsivoglia afflato gioioso e spontaneo.

Il film ribalta ogni convenzione di genere soprattutto per quanto riguarda il rapporto sessuale con l’indigena – normalmente liberatorio, gioioso e all’interno di una dimensione positiva – trasformandolo in un sodalizio (perfino una penetrazione spirituale) con le forze oscure. Con Il corpo Luigi Scattini altera la percezione dello spettatore-medio (che affolla le sale ingolosito dalle nudità della Araya) e ne annulla ogni spasimo erotico trasformando l’icona del sesso libero e naturale nell’incarnazione seducente, ammiccante e serpentina del Male. Un corpo, statuario, levigato, perfetto e dalla pelle vellutata, al servizio del cervello della donna, la quale – con sorprendente e allarmante consapevolezza – è capace di usarlo per ogni sua esigenza: prima fra tutti quella di andarsene dall’isola per trovare non l’amore (come il film sembra presagire) bensì la ricchezza. L’agire di Princess è finalizzato ad acquisire uno status sociale che la allontani da quello della “negra” e “miserabile” – è lei stessa a confessarlo ad Alain quando questi le chiede di fuggire con lui. C’è ne Il corpo una breve sequenza di raccordo in cui la donna, di fronte allo specchio, indossa gli orecchini si prova il vestito giallo, si ammira ammiccante, sorride, per poi strappare tutto con rabbia e gettarlo via consapevole che per ora la chance di fuga non è ancora a porta di mano. Non a caso, subito dopo, rivolgendosi ad Antoine – che si dirige in città per fare compere – le chiede di comprarle un paio di scarpe; l’uomo interdetto, prima le osserva i piedi in silenzio e poi le chiede “Ma da quando tu porti le scarpe?”.

Princess, è l’antitesi di Simon, la donna libera, ingenua, spontanea, semplice e dalla naturale nudità de La ragazza dalla pelle di luna, in quanto donna manipolatrice che usa il suo corpo per secondi fini, che si spoglia con calcolo e premeditazione e che si offre fingendo di donare amore ma in realtà succhiando la vita. Di fronte a Princess, lo spettatore dell’epoca è disarmato perché privato di ogni giustificazione e, improvvisamente, chiamato ad essere responsabile dei suoi pensieri. Se in genere, l’erotico-esotico ha nella sua ontologia la de-responsabilizzazione di chi guarda verso le nudità mostrate in quanto frutto di una distanza sia culturale che spaziale (le nere sono creature “inferiori” e vivono in Africa, luogo che è possibile solo sognare), con Il corpo si trova di fronte ad una donna, sì dalla pelle nera, ma dalla mentalità occidentale, che usa la sua intelligenza per trasformare in “corpi” coloro che ha di fronte e pertanto decisamente inquietante nel suo spogliarsi malizioso. Quest’aspetto è mostrato da Scattini in tutta la prima parte del film – quella in cui Princess non proferisce parola – chiudendo il suo volto in strettissimi e fulminanti primissimi piani e fasciando il suo corpo in un abito rosso fuoco il cui fulgore (a contrasto col nero della pelle) acceca la vista. Quando la donna comincia a parlare – passando dallo status di corpo-oggetto (che subisce le angherie sessuali di Antoine) a quello di essere pensante, gli abiti diventano infantili e rosa confetto non per ingenuità bensì per strategia. È presentandosi come “bambina” infelice, sofferente e piegata dalle vessazioni del rude compagno che riesce a catturare le attenzioni di Alain.

Una volta preso al laccio il giovane imbelle lo manipola a suo piacimento spingendolo a fare tutto ciò che lei vuole. Princess – dietro la dolcezza apparente e dietro i modi affettati – è sottilmente crudele e profondamente infida: come dimostra l’improvviso ricatto sessuale con cui mette spalle al muro l’inconsistente Alain. Ne esce così, un ritratto ambiguo e luciferino della donna, accentuato ancor più dal sorriso estatico e dallo sguardo enigmatico perfettamente integrato con l’ambiente caraibico-invernale in cui il caldo è persistente, la pioggia incessante, l’umidità soffocante e le zanzare non danno tregua. Sin dai titoli di testa, infatti, il regista mostra un oceano bizzoso, grigio e putrescente da cui emergono relitti arrugginiti e resti di navi cannibalizzate. Port-of-Spain è una città caotica fatta di baracche le cui strade sono cosparse di detriti e dove – dietro ad ogni angolo – può esplodere la rabbia e si può essere assaliti dalla violenza per un conto non soldato o per un debito pendente (come puntualmente accade ad Antoine). Ma la capitale di Trinidad è anche una città-approdo in cui vegeta uno come Alain – un uomo troppo stupido per essere vero – che solo grazie alla sua fisicità (il corpo, appunto) riesce a colpire l’attenzione di Antoine salvandolo dal pestaggio di cui è vittima. Alain è un inetto e un ingenuo, un giovane tanto ambizioso (“Io ottengo sempre ciò che voglio” – dice ad Antoine) a parole, quanto vigliacco e incapace nei fatti. In fondo, Alain è proprio un “nessuno” (come viene apostrofato da Antoine durante l’indianata), un corpo e basta: necessario – con i muscoli per fare il lavoro del suo capo mentre lui si crogiola sull’amaca ingollando litri di rhum – e con le mani sia per dare piacere a Princess e sia per farsi armare da lei per uccidere Antoine (senza riuscirci, ovviamente).

In città vive Madeleine, la moglie di Antoine, una donna sola e disperata ma perfettamente lucida nel leggere tra le righe del triangolo che sull’isolotto si agita tra Eros e Thanatos: “Io non mi fido di uno che non ha nulla da perdere e tutto da guadagnare” dice ad Alain poco prima di rivelargli che lei sa che Antoine è morto; “Quella bastarda è capace di tutto” afferma più volte riferendosi a Princess, persino anticipando la possibile fine sua e del marito destinati a rimanere su quell’isola ma come cadaveri.

Questo microcosmo dedito ad un gioco al massacro più per noia che per reali necessità è tratteggiato da Luigi Scattini attraverso nervose riprese con la macchina a mano alternate a lunghi carrelli e panoramiche descrittive. Gli stacchi improvvisi sui primissimi piani dei personaggi trasformano i loro volti in maschere grottesche e diaboliche – così come fa la recitazione: sovraeccitata e teatrale di Enrico Maria Salerno, quella dimessa e monocorde di Leonard Mann [Leonardo Manzella], quella scolastica ed elementare di Carrol Baker e quella per sottrazione – che esalta sguardi ed espressioni – di Zeudi Araya. Ne consegue che ne Il corpo la ripresa in stile documentario – marchio di fabbrica del regista – Luigi Scattini la relega in secondo piano – anche perché in quest’esotismo non c’è nulla di accattivante – isolandola in un’unica sequenza – il Sanctuary dove gli Scarlet Ibis nidificano tra le mangrovie – dal fascino magnetico e dallo scenario meraviglioso. Tutto il film ha un impianto fortemente cinematografico – e non caso visto che si tratta di un racconto equivoco – in cui non si capisce dove finisce la realtà e inizia il sogno – dai tratti fortemente allegorici. Il montaggio più volte, elimina il parlato per lasciare spazio alla musica di Piero Umiliani a commento delle immagini, mentre – altre volte – elimina la colonna sonora per lasciare spazio allo sciabordio delle onde. Scelte che rendono Il corpo un film di difficile classificazione: banale, inconcludente e persino ripetitivo se lo si guarda in maniera superficiale, criptico, ondivago e affascinate se si guarda in profondità e se si entra nell’atmosfera appiccicosa e urticante in cui è avvolta la vicenda.

Negli ultimi venti minuti di pellicola – quelli in cui il regista sembra ammiccare al Roman Polanski degli esordi – il film letteralmente si sfalda dal punto di vista narrativo per lasciare spazio all’immagine e alla sua forza simbolica. Sono i minuti in cui – a livello narrativo – il destino, la casualità e le coincidenze fortuite sembrano alimentare le possibilità di fuga di Alain e Princess, e sono quelli che – a livello figurativo – rivelano la trappola rappresentata dall’esotismo. Tra i fumi neri di un falò sulla spiaggia che si perdono in un cielo altrettanto nero che minaccia tempesta, lei, lui e l’altro inscenano il simulacro di un rito tribale (con danze e fuga in mare a bordo di una barca fatiscente) ad alto tasso alcoolemico destinato a concludersi con il casuale e tragico – quanto ricercato e fortemente voluto – annegamento di Antoine, l’ultimo ostacolo sulla via della fuga, della salvezza e dell’approdo sicuro. Paradossalmente, però, è proprio in quello stesso momento che la fuga diventa negata, perché un altro nemico – invisibile e ben più subdolo – si insinua sotto la pelle dei due giovani pronti a salpare verso l’Europa: la paura. Paura di essere scoperti e quindi bloccati in prigione, ma anche e soprattutto – ed questo che realmente interessa a Scattini – paura di non essere adatti, di essere inadeguati alla vita occidentale. A dimostrazione di ciò ci sono sia il pianto reale di Princess chiusa in camera con il volto – stretto in un primo piano rivelatore della sincerità – appoggiato alle imposte nel momento in cui Alain le rivela che Madeleine sa tutto, sia il modo in cui i due si presentano al check-in della compagnia aerea BOAC (British Overseas Airways Corporation – attiva dal 1939 al 1974) in cui si avverte che persino i vestiti indossati stridono con le reali pretese di libertà dei due. Vestiti che li rendono appariscenti – e pertanto riconoscibili – da Madeline che senza apparente motivo deambula per l’aeroporto chiedendo misteriose informazioni (di cui non si sente il sonoro) a poliziotti e steward.

Luigi Scattini realizza le riprese di questa sequenza sempre mettendo nell’inquadratura, i due giovani in primo piano e – con effetto flou – Madeleine i profondità di campo per mostrare allo spettatore come l’agire della donna influenzi i comportamenti della coppia. E’, quindi, inevitabile che la tragedia si compia, la paura prenda il sopravvento e coincida con una pallottola sparata da un anonimo funzionario che penetra la carne di Alain in fuga sulla pista per far uscire un rivolo di colore rosso che non ha nulla del romantico dei tramonti caraibici bensì il sapore acre e pungente della sconfitta e della disillusione. Alla vista della morte di Alain, Princess compie l’inutile sacrificio di immolare il suo giovane corpo “divino e perfetto” contro il carburatore di una jeep in transito sulla pista dell’aeroporto: la sua morte, è stato l’unico gesto realmente spontaneo della sua breve esistenza, un gesto d’amore estremo e inutile ma che, cinematograficamente, la riconsegna all’immaginario dello spettatore: le strappa di dosso la pelle diabolica del Male per rivestirla del candore dell’innocenza perduta dell’esotismo.
di Fabrizio Fogliato
IL CORPO
Regia/Director: Luigi Scattini
Soggetto/Subject: Massimo Felisatti, Fabio Pittorru
Sceneggiatura/Screenplay: Massimo Felisatti, Fabio Pittorru, Luigi Scattini
Interpreti/Actors: Enrico Maria Salerno (Antonio), Zeudi Araya (Princess), Leonard Mann [Leonardo Manzella] (Alain Breton), Carroll Baker (Madeleine), Luigi Antonio Guerra, Mario Garriba
Fotografia/Photography: Anton Giulio Borghesi
Musica/Music: Piero Umiliani
Costumi/Costume Design: Cristina Lorenzi
Scene/Scene Design: Gastone Carsetti
Montaggio/Editing: Graziella Zita
Suono/Sound: Fiorenzo Magli
Produzione/Production: Filmarpa, P.A.C. – Produzioni Atlas Consorziate
Distribuzione/Distribution: P.A.C.
Censura: 64150 del 06-03-1974




 La sceneggiatura definisce il personaggio di Antoine con tratti hemingwayani e distilla nei dialoghi citazioni – più o meno occulte – di Conrad, dello stesso Hemingway e James Cain. Dell’idea iniziale rimangono l’isolotto di fronte a Trinidad (“luogo ideale e irreale”) e tre personaggi che altro non sono che tre corpi alla deriva aggrappati con le unghie e con i denti, a quel che rimane del sogno caraibico. Personaggi monocordi le cui psicologie sono appena abbozzate così come lo sono le loro origini, nonché gli oscuri motivi che li hanno spinti a ritrovarsi su quei pochi metri di terra, roccia e mangrovie in mezzo all’oceano. Due uomini (Antoine e Alain) e una donna (Princess), più un’altra, Madeleine – moglie di Antoine – che vive sulla terra ferma (a Port-of-Spain) rabbiosi e imbelli, stretti nella morsa del loro egoismo, della loro solitudine e di un caldo soffocante che fa sudare i corpi e annebbia la mente. Giornate trascorse in attesa del nulla, in un inverno caraibico che schiaccia come una cappa opprimente e che toglie il respiro sotto un cielo plumbeo mai così basso e caliginoso. Nessun personaggio positivo, nessuno slancio di generosità, nessuna vocazione alla solidarietà e all’altruismo, nessun contatto né amicale né amoroso – bensì solo sesso fintamente esotico e sodomitico, litri di rhum gelato da ingollare a perdifiato e relazioni oscene perché prive di qualsivoglia afflato gioioso e spontaneo.
La sceneggiatura definisce il personaggio di Antoine con tratti hemingwayani e distilla nei dialoghi citazioni – più o meno occulte – di Conrad, dello stesso Hemingway e James Cain. Dell’idea iniziale rimangono l’isolotto di fronte a Trinidad (“luogo ideale e irreale”) e tre personaggi che altro non sono che tre corpi alla deriva aggrappati con le unghie e con i denti, a quel che rimane del sogno caraibico. Personaggi monocordi le cui psicologie sono appena abbozzate così come lo sono le loro origini, nonché gli oscuri motivi che li hanno spinti a ritrovarsi su quei pochi metri di terra, roccia e mangrovie in mezzo all’oceano. Due uomini (Antoine e Alain) e una donna (Princess), più un’altra, Madeleine – moglie di Antoine – che vive sulla terra ferma (a Port-of-Spain) rabbiosi e imbelli, stretti nella morsa del loro egoismo, della loro solitudine e di un caldo soffocante che fa sudare i corpi e annebbia la mente. Giornate trascorse in attesa del nulla, in un inverno caraibico che schiaccia come una cappa opprimente e che toglie il respiro sotto un cielo plumbeo mai così basso e caliginoso. Nessun personaggio positivo, nessuno slancio di generosità, nessuna vocazione alla solidarietà e all’altruismo, nessun contatto né amicale né amoroso – bensì solo sesso fintamente esotico e sodomitico, litri di rhum gelato da ingollare a perdifiato e relazioni oscene perché prive di qualsivoglia afflato gioioso e spontaneo.